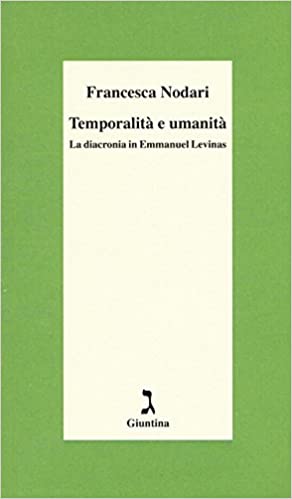 Il concetto di diacronia è forse uno dei capisaldi dell’intera opera levinassiana, insieme a quelli dell’Altro e del Volto. L’importanza di tale tema viene identificato da Francesca Nodari già nell’Introduzione della sua opera quando afferma che «considerare la diacronia come un qualcosa di accessorio piuttosto che il filo rosso attraverso cui si dipana il pensiero incarnato di Levinas esporrebbe al rischio di offrirne una lettura incompiuta e diciamo pure a un’eventuale banalizzazione del suo pensiero liquidandolo come il filosofo del Volto e dell’Altro» (p. 22). Nonostante la centralità di tale tema, Nodari avverte che nella letteratura secondaria vi è, tuttavia, uno spazio vuoto per quanto riguarda la nozione presa in esame.
Il concetto di diacronia è forse uno dei capisaldi dell’intera opera levinassiana, insieme a quelli dell’Altro e del Volto. L’importanza di tale tema viene identificato da Francesca Nodari già nell’Introduzione della sua opera quando afferma che «considerare la diacronia come un qualcosa di accessorio piuttosto che il filo rosso attraverso cui si dipana il pensiero incarnato di Levinas esporrebbe al rischio di offrirne una lettura incompiuta e diciamo pure a un’eventuale banalizzazione del suo pensiero liquidandolo come il filosofo del Volto e dell’Altro» (p. 22). Nonostante la centralità di tale tema, Nodari avverte che nella letteratura secondaria vi è, tuttavia, uno spazio vuoto per quanto riguarda la nozione presa in esame.
È da sottolineare, dunque, lo sforzo dell’autrice che tenta di colmare tale assenza, facendo notare come essa non permetta una “comprensione” profonda di alcune nozioni più tarde, come quella di Illeità, sebbene gli studi su Levinas siano fioriti in seguito all’uscita dei testi inediti, a partire dal 2009, quando vennero pubblicati i Carnets de captivité (tradotti in italiano da S. Facioni: Quaderni di prigionia e altri inediti, Bompiani, Milano 2011). Il corpo a corpo che Nodari ingaggia con i testi levinassiani è sottolineato anche da Bernhard Casper – a cui l’opera è dedicata e che ha curato la Premessa al testo – il quale nota che «Francesca Nodari indaga il cuore della connessione interna tra temporalità e umanità, ossia il suo verificar-si diacronico inteso come l’accadere della vera libertà, cioè della salvezza sperata per l’uomo» (p. 15).
Il testo prende le mosse da una domanda che riguarda il nostro tempo: il problema che sta a cuore all’autrice è quello di attualizzare il concetto di diacronia e porlo in un contesto, come quello contemporaneo, in cui «la crisi, ancora prima che economica, è etica e morale» (p. 19). Difatti, ne emerge una “fenomenologia del mondo globalizzato”, secondo la quale il soggetto moderno – apice di un percorso che passa attraverso il soggetto trascendentale husserliano e il «Dasein che-non-ha-mai-fame» (p. 23) – vive in una Umwelt scandita dal tempo sincronico. Il mondo in cui viviamo, in altre parole, si basa sull’assenza di tempo; sul tempo degli orologi, che impone l’economicità dell’esserci, invece che il suo incontro con l’alterità. Così, il tipo d’uomo che si può incontrare è quello solo, timoroso del domani, ansioso, incerto. Calzante, a tale proposito, è la domanda che pone l’antropologo Marc Augé: «Non sarà che oggi, la paura della vita abbia rimpiazzato la paura della morte?» (p. 46).
A quest’uomo indifferente a tutto, per cui tutti i valori sono posti sullo stesso piano, si oppone la gratuità, la quale non va confusa con ciò che è gratis, che presuppone ancora una concezione economica della realtà. Nodari, a questo proposto, mette in luce il concetto di dono, utilizzando Derrida, per mostrarne le aporie intrinseche, ma compiendo un passo ulteriore con Levinas, proprio attraverso il tema della diacronia.
Derrida mostra, di contro a Mauss, che il dono può essere tale esclusivamente se non viene ricambiato, tant’è che parlare di dono scambiato è una contraddizione: suggerisce, dunque, di obliare il fatto stesso che ci sia stato un dono, sia da parte di chi dona sia da parte di chi riceve. Nodari, però, nota che non è possibile confinare il dono nell’oblio e, inoltre, appiattire «l’atto stesso del donare sullo scrivere» (p. 71). Parlare, infatti, vuol dire sconvolgere l’egoità stessa dell’io; significa «fare segno a “una ragione che parla, [che] esce dal suo splendido isolamento, [che] tradisce la sua superba indifferenza, [che] abdica alla sua nobiltà”» (pp. 73-74).
Tuttavia, ciò di cui bisogna essere grati è la nostra stessa creazione, cioè, secondo Levinas, di essere stati eletti, ovvero, essere io vuol dire poter rispondere all’appello di Dio attraverso l’«Eccomi», in una elezione che mi rende responsabile. La creazione è in stretto legame con una delle nozioni chiave del pensiero del filosofo lituano, cioè quello di fecondità: «Perché si dia davvero il dono, occorre per un verso che l’esserci sia accogliente, per l’altro – perché il dono si realizzi in tutta la sua verità – che l’“io sono” dia prova della propria fecondità portando il frutto di una umana gratitudine “che partorisca a sua volta (widergebärende Dankbarkeit)”» (p. 101). La grazia dell’elezione, allora, è questo poter rendere grazie del fatto stesso di trovarsi in una condizione simile, cioè il ringraziare di poter ringraziare.
L’ultimo capitolo della prima parte dell’opera è un confronto tra Levinas e Blanchot, che si esplica attraverso il concetto di felix culpa, presente già nei Carnets, che non sarebbe altro che il «dovere felice di amare l’altro» (p. 107).
La contaminazione reciproca di questi due pensatori è messa in evidenza da Nodari attraverso alcune nozioni levinassiane, come “parola parlante” e “parola parlata”: la prima riguarda il Dire, quindi rimanda a quel linguaggio che lascia apparire Altri; la seconda, invece, fa capo al Detto, riferendosi in questo modo al mondo della luce e del potere. In Blanchot queste nozioni sono tradotte nella “parola plurale”: lo scrittore porta a una irrimediabile scelta tra il parlare e il vedere, cioè tra il mondo della distanza e quello della prossimità. Ma la “parola plurale” è diacronica, in quanto il “parlare” apre una fessura tra due interlocutori che non è possibile colmare, un intervallo che «non è né dell’essere né del non-essere» (p. 118); fessura che misura una distanza tra il supplice, quello che Levinas chiamerebbe il Volto dell’Altro, e il suo interlocutore. La figura del supplice esprime, inoltre, attraverso la parola che mostra la Traccia, direbbe Levinas, la presenza invisibile del suo dio. Il tempo che il supplice inaugura è quello diacronico, che Blanchot individua attraverso un movimento che chiama «l’Attesa, l’Oblio» (p. 121), un tempo che si allontana, ma che conserva un rapporto con il passato. L’Oblio, la diacronia, permette di andare incontro ad altri, nel tempo, in cui il sé e l’altro sono «insieme ma non ancora» (p. 123).
La seconda parte del testo mette in relazione i temi fondamentali intorno a cui ruota il lavoro di Nodari, ovvero cerca di indagare la nozione di bonum commune, evidenziando come esso non possa non svolgersi attraverso il tempo, attraverso la diacronia, che si fonda sull’Altro.
Il ritorno del tema della fecondità, in questa parte, è necessario per spiegare come Levinas intenda il tempo innanzitutto come sessualità, come «dramma in più atti»: la paternità, da intendere non biologicamente, ma in base alla figura del Maestro, è ciò che permette di unire i due istanti dell’atto che si susseguono e che si legano, proprio attraverso il rapporto del padre con il figlio: «L’amore paterno è precisamente l’evento concreto della mia transustanziazione in un altro me che insieme è me e non è me» (p. 138). Solo attraverso la fecondità è possibile comprendere la nozione di bene, che si inserisce tra i due istanti: il secondo è il ri-cominciamento del primo, è la sua assoluzione. La «Bontà del Bene» non sarebbe altro che l’anteriorità del Bene rispetto alla libertà, cioè la convocazione che mi chiede di rispondere e che crea uno scarto tra me e il Bene: «Diacronia: differenza insormontabile tra il Bene e me, senza simultaneità dei termini divisi» (p. 143). Elezione e passività che segnano la distanza dal pensiero heideggeriano, ribadendo che la «salvezza non è l’essere» (p. 144).
Il bene, al di là dell’essere, inteso come bonum commune, deve essere visto secondo il messaggio evangelico dell’amore verso il prossimo e verso Dio: il primo è riconducibile al pensiero pratico, al «bonum, quo quis bonum fit» agostiniano, che si esplica nel tempo; il secondo è relativo al tempo sincronico, al «bonum quod». La visione agostiniana, in un certo senso, anticipa «il primato [kantiano] della ragion pratica pura nel suo collegamento con la ragione speculativa” (p. 154).
A questo punto Nodari si domanda quale senso abbia per noi uomini e donne del XXI secolo la nozione di bonum commune esaminata finora. La risposta deriva dal pensiero di Franz Rosenzweig, che equipara il bisogno dell’altro alla serietà con cui si prende il tempo, inaugurando un «nuovo pensiero», che non può prescindere dal tempo, rigettando il precedente, basato sulla sincronia e sull’immobilità: il tempo è legato all’alterità e alla parola.
Ma la parola, avverte Nodari, non è quella che Heidegger “declassa” a mera chiacchiera, anzi, solo attraverso di essa vi è un possibile collegamento tra il Maestro e l’allievo, quindi tra il Medesimo e l’Altro, proprio perché il linguaggio porta con sé il tempo, l’intervallo di tempo tra i due istanti che ne formano il dramma. Alla chiacchiera, Levinas contrappone l’invocazione, l’insegnamento non maieutico, che non è un mero tirare fuori ciò che già è in me, ma è bisogno dell’altro.
La trascendenza dell’Altro è salvaguardata solo se il rapporto tra allievo e Maestro è diacronico, non riportato all’intenzione, la quale annullerebbe la distanza che la parola mantiene e nella quale si mantiene. L’alterità che sconvolge il sé non può che essere tempo e il bene può essere cercato solo laddove l’Altro mi sconvolge: sé che non è altro che un «io sono di carne e sangue», formula che Nodari utilizza per significare la finitezza, definita dalla corporalità, dell’esserci, di contro al soggetto idealistico, al «Dasein che-non-ha-mai-fame».
È così possibile comprendere l’equazione chiave del testo: «la temporalità sta all’umanità come la diacronia sta all’“allora insegnato”» (p. 194). In altre parole, solo in un essere temporale risiede l’umanità, in quanto la sua dignità è tale proprio nella risposta all’elezione, alla chiamata dell’Altro, al quale non si può che rispondere «Eccomi»: solo attraverso il tempo è possibile che questa «passività più passiva» possa essere feconda e dunque responsabile dell’insegnamento, dell’“allora insegnato”, più immemore di ogni passato.
Questa passività, che tuttavia sottintende sempre un residuo di attività, quando si va incontro all’altro, non può che esplicarsi nella misericordia, a cui è dedicata l’ultima parte del saggio. Dopo una breve rassegna storica del termine “misericordia”, Nodari tenta di tratteggiarne un nuovo paradigma, attraverso il quale bisogna farsi carico del dolore altrui, ma non in un donare ipocrita che non si cura del supplice, attento solo al proprio gesto, bensì in una presa su di sé di tutto il dolore dell’altro, fino a stare male, a essere vulnerabili. Partecipazione della sofferenza dell’Altro, la quale scuote come Gesù è scosso dal dolore di ogni creatura, per la quale egli sacrifica tutto se stesso. La necessità di questo nuovo paradigma morale è data dalla dimenticanza «della nostra finitezza e mortalità» e «dell’alterità irraggiungibile di Autrui» (p. 207).
Si comprende così la conclusione dell’autrice: «Perché […] senza l’altro, la nostra vita perderebbe di senso e ogni percorso intrapreso non sarebbe altro che un sentiero interrotto» (p. 229).
venerdì , 22 Novembre 2024
Ultime notizie
- 184. Recensione a: Adriano Prosperi, Machiavelli. Tra religione e politica, Officina Libraria, Roma 2024, pp. 168. (Cristiano Barbieri)
- 183. Recensione a: Vittorio Gallese, Ugo Morelli, Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente, Cortina, Milano 2024, pp. 230. (Giulia Castagliuolo)
- 182. Recensione a: Claudio Bonito, Alberto Carrara (a cura di), Il transumanesimo. Una sfida antropologica alla scienza e alla fede, Mimesis, Milano-Udine 2024, pp. 120. (Sarah Dierna)
- 181. Recensione a: Luca Crescenzi, L’esploratore e la fine del tempo. Franz Kafka e il ciclo di racconti Un medico di campagna, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2024, pp. 252. (Enrico Palma)
- 180. Recensione a: Alexander Schnell, Le clignotement de l’être, Hermann, Paris 2021, pp. 319. (Tommaso Bigatti)
- 179. Recensione a: Gabriel Marcel, Il filosofo di fronte al mondo d’oggi, a cura di G. Scarafile, Morcelliana, Brescia 2024, pp. 96. (Andrea Allegra)
- 178. Recensione a: Eleonora Caramelli, Poetiche del testo filosofico. Hegel, Merleau-Ponty e il linguaggio letterario, Carocci, Roma 2024, pp. 154. (Matilde Mezzadri)
- 177. Recensione a: Antonino Pennisi, L’ottava solitudine. Il cervello e il lato oscuro del linguaggio, il Mulino, Bologna 2024, pp. 189. (Caterina Scianna)
- 176. Recensione a: Giovanni Cerro, Tra natura e cultura. Degenerazione, eugenetica e razza in Giuseppe Sergi (1841-1936), ETS, Pisa 2024, pp. 326. (Giovanni Frascà)
- 175. Recensione a: Enrico Palma, De Scriptura. Dolore e salvezza in Proust, Mimesis, Milano-Udine 2024, pp. 270. (Sarah Dierna)

 English
English

