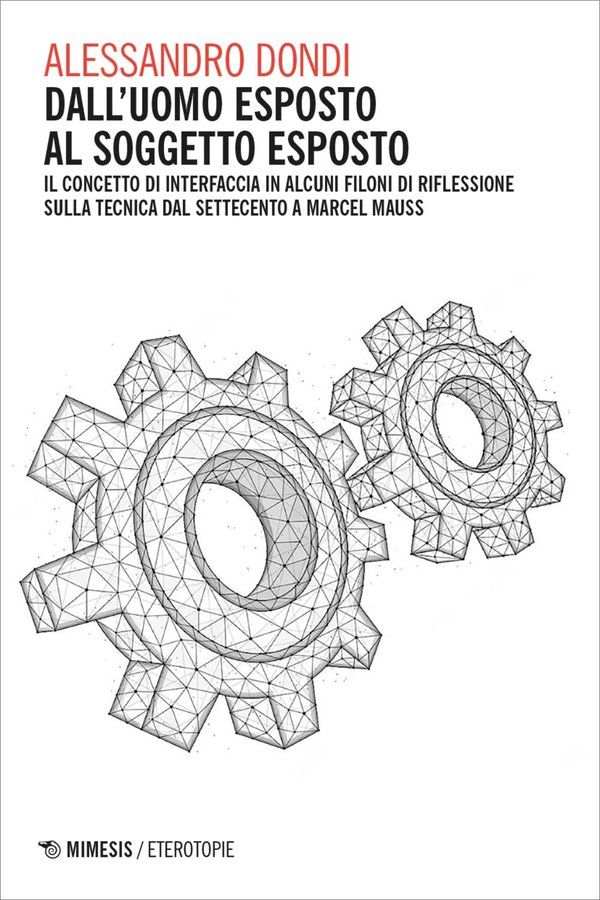 L’ultima opera di Alessandro Dondi, Dall’uomo esposto al soggetto esposto, è costruita attorno a due concetti che si può dire rimandino a un’unica idea: quella della relazione tra due sistemi di relazioni, sistemi che possiamo chiamare, nel modo più generale, quello dell’interno – il nodo di relazioni, il centro di rifrazione fra rapporti che costituisce gli “enti” – e quello dell’esterno – l’orizzonte infinitamente aperto di relazioni nel quale tali enti si trovano a vivere e interagire. Con le parole dell’autore, questi due concetti convergenti sono “la figura dell’interfaccia come ciò che demarca un rapporto di inerenza e di separazione tra un interno e un esterno che hanno, tra loro, un rapporto necessario e tuttavia contingente, e la figura della relazione di ‘esposizione’, tramite la quale si vuole pensare a forme di soggettività vulnerabili, esposte alle relazioni e ai concatenamenti, nei quali sono inserite e che tuttavia non possono che essere origine di ulteriori forme di esposizione andando a modificare altre soggettività e l’ambiente di vita comune” (p. 32). È perché il sistema relazionale “interno” in qualche modo deriva da quello “esterno”, come un arresto del suo divenire o un’interiorizzazione – una piega – delle stesse relazioni che costituiscono l’esterno, che l’ente è sempre “esposto”, è perché esso non può mai rendersi impermeabile all’influenza e persino alla violenza esercitata dal fuori che la questione dell’interfaccia tra interno ed esterno diventa un tema filosofico.
L’ultima opera di Alessandro Dondi, Dall’uomo esposto al soggetto esposto, è costruita attorno a due concetti che si può dire rimandino a un’unica idea: quella della relazione tra due sistemi di relazioni, sistemi che possiamo chiamare, nel modo più generale, quello dell’interno – il nodo di relazioni, il centro di rifrazione fra rapporti che costituisce gli “enti” – e quello dell’esterno – l’orizzonte infinitamente aperto di relazioni nel quale tali enti si trovano a vivere e interagire. Con le parole dell’autore, questi due concetti convergenti sono “la figura dell’interfaccia come ciò che demarca un rapporto di inerenza e di separazione tra un interno e un esterno che hanno, tra loro, un rapporto necessario e tuttavia contingente, e la figura della relazione di ‘esposizione’, tramite la quale si vuole pensare a forme di soggettività vulnerabili, esposte alle relazioni e ai concatenamenti, nei quali sono inserite e che tuttavia non possono che essere origine di ulteriori forme di esposizione andando a modificare altre soggettività e l’ambiente di vita comune” (p. 32). È perché il sistema relazionale “interno” in qualche modo deriva da quello “esterno”, come un arresto del suo divenire o un’interiorizzazione – una piega – delle stesse relazioni che costituiscono l’esterno, che l’ente è sempre “esposto”, è perché esso non può mai rendersi impermeabile all’influenza e persino alla violenza esercitata dal fuori che la questione dell’interfaccia tra interno ed esterno diventa un tema filosofico.
E non solo filosofico, poiché è soprattutto a causa della “crisi ambientale” che essa entra nell’orizzonte della visibilità contemporanea: quella di Dondi è un’opera di teoria ecologica, intesa in senso ampio, perché problematizza proprio il modo in cui quell’ente particolare che è l’umano si relaziona – si interfaccia – col suo ambiente, aspetto che emerge forse al meglio con l’analisi del lavoro di Jean-Baptiste Fressoz (cfr. pp. 63 sgg.), e che Dondi affronta apertamente in quella che è forse la più antica forma di approccio ecologico, i discorsi settecenteschi sulla “igiene sociale”. È così a partire da un orizzonte problematico pienamente contemporaneo che Dondi effettua la sua ripresa di un insiemi di dibattiti che spaziano dalla fine del Settecento fino agli anni più recenti; ed è questo stesso orizzonte problematico che, grazie alla capacità dell’autore di rintracciare con minuzia quanto di funzionale all’elaborazione dei due concetti centrali dell’opera, conferisce unità a uno sciame di autori – Canguilhem, Rousseau, Buffon, Mauss, Durkheim, Reuleaux, La Caze fra gli altri – la cui combinazione rischierebbe altrimenti di apparire piuttosto rapsodica (il sottotitolo del libro, dopotutto, fa un riferimento generico ad “alcuni filoni di riflessione sulla tecnica”). È seguendo queste fila sottili che il libro affronta un dibattito la cui solidarietà emerge forse solo a partire da esso.
Che ente e ambiente siano tanto strettamente correlati può apparire quasi come un’ovvietà, tanto che la pertinenza ecologica della stessa nozione di “ambiente” come quadro esteriore in cui gli “individui” sarebbero inseriti potrebbe essere discussa – come fatto, tra gli altri, da Bruno Latour e Peter Sloterdijk. Rispetto a questi pensatori, la costruzione teorica di Dondi ha il vantaggio di salvaguardare una certa visione di ciò che è “interno”, di un privato ontologico che, per quanto mai chiuso, non si lascia ridurre all’esterno. Piuttosto, interno ed esterno sono reciprocamente “espressivi”; essere umano e ambiente sono “chiastici” – termine questo, come quello di piega, che si applica in maniera non arbitraria al discorso di Dondi poiché, come Manlio Iofrida ricorda nella Prefazione e come mostra lo stesso autore scoprendo le carte nella Conclusione, la “fenomenologia ecologica” di Merleau-Ponty resta il grande punto di riferimento dell’autore e un costante accompagnamento del suo pensiero: “Merleau-Ponty, attraverso la propria concezione dell’Essere come interfaccia, come chiasma, propone un’ontologia della complementarietà tra interno ed esterno, un’ontologia che non fa dell’umano un regno separato dal proprio ambiente” (p. 383).
Ambiente che non è solo quello “naturale”: con l’ingresso di Mauss nel panorama teoretico dell’opera (cfr. pp. 242 sgg.), l’interfaccia non è più solo quella tra individuo e ambiente ma anche quella tra individuo e società. Facendo convergere Mauss e Durkheim, il concetto di interfaccia porta a vedere che “l’individuo è tale attraverso il sociale, due elementi che non possono essere separati. È l’origine dei due poli ad essere separata e scissa. Il polo individuale, le rappresentazioni individuali, sono costituite dalla relazione tra l’individuo e l’ambiente fisico, mentre il polo sociale, le rappresentazioni collettive, sono costituite dalla relazione tra l’individuo e l’ambiente sociale” (p. 262). I sistemi di relazioni da cui siamo partiti si rifrangono: l’interfaccia diventa interna al soggetto, diventa, potremmo dire, “intra-faccia” che pone individuo fisico e individuo naturale l’uno di fronte all’altro, proprio perché l’esterno è a sua volta sdoppiato in fisico e sociale.
A mettere in comunicazione questi due lati è la tecnica, dispositivo di soggettivazione e umanizzazione che finisce per retroagire sull’ambiente stesso in una continua opera di terra-ri-formazione. Proprio la tecnica è il denominatore comune degli autori ispezionati da Dondi (verrebbe da chiedersi, a questo proposito, se Gilbert Simondon non si sarebbe inserito con naturalezza in un panorama discorsivo che fa di tecnica e individuazione due pilastri concettuali). Non è un passo accidentale quello che porta a vedere la tecnica quale forma principale che l’interfaccia assume per l’umano: “L’habitat, come la tecnica, è costituito da due piani che sono due relazioni tra loro inscindibili, uno tra l’uomo e la materialità della natura, l’altro tra l’uomo e le istituzioni sociali […] L’uomo totale, che è uomo concreto, esistente, è la fessura che passa tra i due lati della ‘causalità reciproca’ attraverso la quale l’uomo mentre crea, crea sé, e mentre ‘fa’, ‘fa il suo sé’, mentre è ‘disposto’ diviene ‘disposizione’ (habitus)” (p. 356).
“Tra queste relazioni l’uomo ha perso ogni ‘natura’ propria, ogni sostanza, l’uomo diviene un vuoto che non è un nulla, un’apertura, un’istanza evacuata, è ciò che è provocato ed esposto, è un essere, la cui essenza (interiore) è la relazione con l’esterno” (p. 356). Ogni sostanzialismo è superato perché dal primato della sostanza si passa al primato della relazione: se assumere un mondo popolato di sole sostanze autonome porta al noto rischio di un regresso infinito che impedisce di spiegare l’entrata in relazione delle sostanze, il concetto di relazione contiene già in sé la possibilità di interagire e fare catena con altre relazioni per innescare un processo di “individuazione”, di aggregazione delle relazioni che vanno così a formare quella che, conferendole un’illusoria autonomia, chiamiamo poi “sostanza”. Contro tutta la tradizione aristotelica, le relazioni non sono un che di secondario che “sopravviene” sulle sostanze; al contrario, “l’interfaccia è il doppio lato di un interno e un esterno che non preesistono alla loro relazione e il doppio lato dei singoli passaggi, delle singole resistenze, delle modificazioni e delle trasformazioni” (p. 386). Il corpo stesso – che, come per Rousseau, costituisce il primo strumento tecnico, una sorta di archi-strumento (p. 192) – è modificato in modo essenziale da abitudini, educazione e climi perché, come mostra La Caze, il corpo “non è una sostanza, bensì il luogo di una relazione che non preesiste alla relazione stessa, relazione che è produzione continua e ricorsiva di un interno e di un esterno” (p. 129).
Abbiamo parlato finora di un soggetto che nasce come piega del fuori; sarebbe forse ancora più corretto parlare dell’interfaccia come della “differenza interna”, della relazione ancora implicata il cui dispiegarsi dà luogo ai due poli “tra” i quali la relazione sta. Se nella prima citazione riportata il rapporto di esposizione nei confronti dell’ambiente era definito insieme “necessario e contingente” è perché, se da un tale rapporto non si può prescindere, la forma da esso assunta non è mai preordinata dal solo essere dell’ambiente o della società, né da quello del soggetto esposto, né da una qualunque loro somma: questo è ciò Dondi definisce “la non determinatezza della relazione”, a indicare che la relazione non è mai data in anticipo ma viene a determinarsi solo nel processo di ontogenesi col quale lascia emergere i propri poli. Si potrebbe dire che la relazione è un’entità intrinsecamente temporale proprio perché non ha alcuna “essenza”, ma coincide quasi senza resto col processo della propria determinazione e dell’emergenza dei propri poli. Ed è per questo stesso motivo che cercare qualunque “completezza” e autonomia nelle sostanze è opera vana: “la relazione di esposizione significa che l’interno […] necessita, per esistere, di qualcosa che non gli appartiene. L’interno è esposto a ciò a cui l’interno è debitore per esistere. Dell’interno non è possibile fornire alcuna nozione completa in quanto è pensato attraverso la sua esistenza e non la sua essenza” (p. 132). Questo processo di emergenza da una relazione auto-differenziantesi, e la necessità di volgersi indietro verso tale relazione per poter ottenere un qualche potere sull’opposto polo “esterno”, è ciò che Dondi, riprendendo un termine antico, chiama “ecfrasi”: il tipo di pensiero cui l’opera di Dondi punta è precisamente un sapere “ecfrastico”, “una pratica di sapere che si posiziona sulla soglia tra l’interno e l’esterno che sappia così dar luogo al ‘correlarsi descrivendo’” (p. 197 nota), ben esemplificato dalla “mesologia” di Augustin Berque (p. 198 nota), alla quale Dondi sembra quasi voler fornire un presupposto metafisico.
E il “tra” della relazione rimanda anche al secondo concetto-protagonista, quello dell’esposizione che l’ente conserva nei confronti dell’ambiente. Esposizione, dunque fragilità, ma anche “resistenza”. Quella piega interiorizzante che costituisce il soggetto non scompare in ogni momento perché acquisisce una relativa stabilità, che passa soprattutto dalla ri-determinazione dell’ambiente affinché questo permetta il mantenersi delle forme di soggettività che ha disposto: “Alla soggettivazione corrisponde sempre anche una oggettivazione che dà forma a istituzioni e infrastrutture” (p. 357). Il rischio contro cui Dondi mette in guardia ricorda la critica che William James muoveva alla definizione spenceriana dell’attività mentale come “il crescente aggiustamento delle relazioni interiori a quelle esteriori” (cfr. H. Spencer, The Principles of Psychology): non si tratta, ribatte James, di un mero aggiustamento passivo, ma dell’attiva selezione che il soggetto opera e che condiziona ricorsivamente il suo stesso essere-soggetto. Ciò che Dondi aggiunge – dopo aver esposto un punto pressoché identico, attraverso non James ma Merleau-Ponty (p. 380) – è che in primo luogo è la tecnica a compiere quest’opera di riforma attiva dei dintorni, e che in secondo luogo ciò è possibile solo perché la tecnica è fin dal principio modalità di interfaccia con l’ambiente. L’opposizione tra attività e passività che ancora si trovava nella replica di James è superata, perché i due poli non sono in opposizione ma sono i due aspetti inseparabili del costituirsi relazionale del soggetto di fronte al suo ambiente. A emergere dal discorso di Dondi è insomma la natura intrinsecamente “ecologica” della tecnica, nel duplice senso che si tratta di un’attività che punta alla gestione delle “relazioni esteriori”, e che sono queste relazioni ambientali stesse a renderla in primo luogo possibile: “La tecnica, tramite il legame che instaura tra l’uomo e la natura, modifica il modo di concepire la natura e con essa tutti i legami e i rapporti che la intessono. L’uomo è esposto alla tecnica, essa diviene parte della sua facoltà attiva e, tramite essa, l’uomo si modifica e modifica i rapporti con il mondo, con gli altri uomini, ma anche con il proprio passato e la propria storia, con il proprio ambiente di vita e con l’ambiente di vita degli altri esseri viventi non umani” (p. 368).
La prassi umana, spiega ancora Dondi reiterando l’idea classica dell’antropologia filosofica che il tratto distintivo dell’umano sia il rapporto “negativo” che è capace di instaurare col mondo, consiste proprio in una “dialettica” che è allo stesso tempo rifiuto dell’ambiente dato e sua riformazione e completamento tramite l’aggiunta di nuovi “livelli” che, con Merleau-Ponty, si possono definire “simbolici”, ma che in senso più specifico potrebbero anche essere qualificati come tecnici (p. 381). Ciò che l’antropologia filosofica non aveva forse colto con sufficiente profondità, e che il complesso itinerario storico-teoretico di Dondi lascia emergere, è come questa negazione non sia una semplice relazione diadica tra due termini fissi; come la dialettica non sia solo tra i poli ma sia una dialettica interna a essi; come l’interfaccia vada colta insomma come luogo di una doppia dialettica, da un lato come “soglia reversibile tra l’interno e l’esterno” a causa della quale “la soggettività dell’individuo è espressione del suo ambiente mentre l’ambientalità di ciò che lo circonda è ciò che è sempre appropriato (nel doppio senso di fatto proprio e di giusto) per l’espressione creativa del soggetto”; dall’altro come “relazione tramite la quale l’interno e l’esterno si costituiscono e si modificano reciprocamente tramite passaggi e resistenze” (p. 385). Si tratta, insomma, della compresenza di “una dialettica verticale che indica l’inerenza di un interno che si costituisce come sfondamento rispetto a un piano ambientale (naturale, storico, sociale, culturale) di cui esso è l’altro lato, attivo e soggettivo”, e di “una dialettica orizzontale per la quale l’interno viene penetrato, frastagliato, infra-strutturato dall’esterno; per la quale, le forze proprie dell’interno sono forze latenti provocate dall’esterno” (pp. 385-386). Una dialettica è costitutiva, rende conto della genesi dell’ente a partire dall’ambiente; l’altra è, per così dire, esistenziale, rende conto insieme del permanere del soggetto nonostante le pressioni esterne e del suo continuo modificarsi sotto la loro spinta. Il soggetto emerge e persiste come un nodo relazionale in equilibrio instabile sull’orlo delle relazioni ambientali che l’hanno portato a essere.
La scissione interna al soggetto e all’ambiente tra un aspetto naturale e uno sociale viene moltiplicata una volta di più, viene rifratta da questa nuova scissione tra dialettica verticale e orizzontale. E si potrebbe aggiungere un terzo punto di rifrazione, al quale Dondi accenna soltanto, ma che sembra una preoccupazione primaria della sua ricostruzione: “L’interfaccia è anche il luogo in cui si producono le controversie e le lotte tra soggetti-ambienti che non sono indifferenti gli uni agli altri” (p. 386); allora, la nozione di interfaccia permette di “riaprire le controversie e le lotte del passato cogliendole come momenti in cui due o più mondi (o soggetti-ambienti) sono entrati in un contatto trasformativo” (p. 387). L’interfaccia si fa “interfaccia storica” perché diviene il luogo in cui diversi “mondi” si scontrano, dove delle “trasformazioni che sfondano, con un taglio verticale, infrastrutturale, il mondo culturale e sociale coinvolgendo i corpi, l’ambiente, la natura” (p. 389) si fronteggiano mettendo a confronto le loro esigenze spesso confliggenti e determinando a lungo andare chi debba aver ragione dell’altro. La prassi ecologica, che comprende l’instaurazione della questione ecologica non solo come “evidenza scientifica” ma come orizzonte esistenziale della contemporaneità, è forse l’esito ultimo del percorso di Dondi, e l’ecologia, più che come “scienza dell’ambiente”, potrebbe arrivare a essere efficacemente descritta come “pratica dell’interfaccia”.
(6 febbraio 2024)

 English
English

