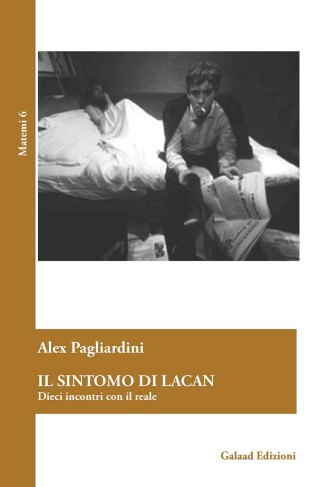 Tra i lettori e interpreti di Lacan è diffusa una tentazione: quella di decifrare la sua parola. Posti di fronte alla straordinaria complessità del suo insegnamento, a essere perlopiù solleticata è la smania della disambiguazione. In alcuni si sente proprio quel gusto della trovata, della chiave che consente di sciogliere l’enigma. L’ultimo libro di Alex Pagliardini, Il sintomo di Lacan – lo stesso potrebbe dirsi per il precedente dedicato al trauma del linguaggio – , si tiene a debita distanza da questa attitudine di lettura. Non c’è nulla da decifrare nel discorso di Lacan, semmai c’è qualcosa che bisogna imparare a toccare, a incontrare. C’è qualcosa che arde lì sotto, quando Lacan prende la parola; il più delle volte si tratta di un’esperienza puntuale, semplicissima, condivisa da tutti, ma che per essere incontrata in tutte le sue sfumature richiede la pazienza e il gusto del détour, nel doppio senso della divagazione e della circumnavigazione. Se decifrare un testo significa individuarne una chiave capace di convertire l’opacità in limpidezza, l’insegnamento di Lacan è piuttosto caratterizzato dal vivo senso di una imminenza. Quella di Lacan è una parola imminente, intrisa cioè di una presenza a venire. L’imminenza ha già infatti tutto il sapore della presenza, pur essendo sempre in procinto di. Potrei dire un po’ provocatoriamente che se ci si esercita a tenere a debita distanza la decifrazione, si scopre d’un tratto che Lacan ci sta, ad esempio, parlando dell’orgasmo, oppure di quel perturbamento che ci invade quando troviamo qualcosa al posto di una mancanza, o una mancanza al posto di qualcosa, oppure ancora dell’angoscia che si prova quando si diventa oggetto per un altro. E potrei proseguire per pagine e pagine, perché Lacan sapeva mirabilmente isolare l’assoluta particolarità di ciascun nostro modo di incontrare la vita e conosceva l’arte di farcene sentire, appunto, l’imminenza.
Tra i lettori e interpreti di Lacan è diffusa una tentazione: quella di decifrare la sua parola. Posti di fronte alla straordinaria complessità del suo insegnamento, a essere perlopiù solleticata è la smania della disambiguazione. In alcuni si sente proprio quel gusto della trovata, della chiave che consente di sciogliere l’enigma. L’ultimo libro di Alex Pagliardini, Il sintomo di Lacan – lo stesso potrebbe dirsi per il precedente dedicato al trauma del linguaggio – , si tiene a debita distanza da questa attitudine di lettura. Non c’è nulla da decifrare nel discorso di Lacan, semmai c’è qualcosa che bisogna imparare a toccare, a incontrare. C’è qualcosa che arde lì sotto, quando Lacan prende la parola; il più delle volte si tratta di un’esperienza puntuale, semplicissima, condivisa da tutti, ma che per essere incontrata in tutte le sue sfumature richiede la pazienza e il gusto del détour, nel doppio senso della divagazione e della circumnavigazione. Se decifrare un testo significa individuarne una chiave capace di convertire l’opacità in limpidezza, l’insegnamento di Lacan è piuttosto caratterizzato dal vivo senso di una imminenza. Quella di Lacan è una parola imminente, intrisa cioè di una presenza a venire. L’imminenza ha già infatti tutto il sapore della presenza, pur essendo sempre in procinto di. Potrei dire un po’ provocatoriamente che se ci si esercita a tenere a debita distanza la decifrazione, si scopre d’un tratto che Lacan ci sta, ad esempio, parlando dell’orgasmo, oppure di quel perturbamento che ci invade quando troviamo qualcosa al posto di una mancanza, o una mancanza al posto di qualcosa, oppure ancora dell’angoscia che si prova quando si diventa oggetto per un altro. E potrei proseguire per pagine e pagine, perché Lacan sapeva mirabilmente isolare l’assoluta particolarità di ciascun nostro modo di incontrare la vita e conosceva l’arte di farcene sentire, appunto, l’imminenza.
Cogliere questa zona fremente che pulsa dietro e attraverso la parola è la sfida di Pagliardini. Egli la insegue in dieci percorsi che sono altrettanti modi in cui il corpo si dispone a incontrare il reale appunto. Per darci il senso dell’imminenza dell’incontro col reale, Pagliardini si porta dietro, in ogni frase, tutto Lacan. Ogni suo passo in avanti ricapitola l’intero percorso per aggiungervi una piccola variazione, un tassello nuovo. Ripetizione, ricapitolazione e variazione sono la cifra dello stile di Pagliardini e insieme il modo di far sentire al lettore come il registro del reale sia, ripetiamolo, dell’ordine dell’imminenza. Si tratta di una sorta di inseguimento non privo di fatica e di tensione, come tutti gli inseguimenti.
Se dovessi individuare un’immagine che evochi i tratti salienti dello stile di Pagliardini, la troverei nella figura di Alfeo. Nell’antica leggenda, Alfeo è una divinità fluviale che si innamora della ninfa Aretusa la quale, per fuggire al suo corteggiamento, si rifugia in Sicilia dopo essere stata trasformata in fonte. Alfeo prega Zeus di deviare il suo corso, facendolo scorrere sotto il Mar Ionio, per sfociare nell’isola di Ortigia ricongiungendosi con l’amata Aretusa. La leggenda allude a una deviazione, per amore, dal corso abituale, tale tuttavia da preservare l’integrità di Alfeo che riesce a tenere unite le sue acque, pur scorrendo in gurgite vasto. Ecco, Pagliardini si porta sempre dietro tutte le acque di Lacan. Certamente la sua attenzione si concentra sugli esiti dell’insegnamento di Lacan, vale a dire sull’ultimo periodo in cui il tema del reale si affaccia con forza fino a dominare la scena. Eppure, questo libro è animato dalla convinzione che a tale esito si arrivi non con un salto, con una brusca inversione di rotta, bensì con una sorta di deflusso che trascina con sé tutte le acque.
Come possiamo dunque incontrare il reale? Il sintomo di Lacan vuole provare a rispondere a questa domanda. Innanzitutto va detto che del reale non si dà sapere. Il reale non lo si può conoscere, non lo incontriamo sul piano del senso. Occorre svezzarsi dal senso, ci suggerisce Pagliardini, riprendendo un’espressione di Miller. Ciò non significa che il reale sia inconoscibile. L’inconoscibile è infatti, come ha ben mostrato Badiou, ancora sotto l’ala della conoscenza sebbene via negationis, e assume i tratti dell’indeterminato, dell’ineffabile, del confuso, dell’incerto. Al contrario, il reale è piuttosto qualcosa di molto preciso, di indubitabile, di certo, che sfugge alla conoscenza non per difetto, ma per una sorta di perenne eccedenza. Dalla sua incontrovertibile presenza, il reale produce effetti a nostra insaputa. Mendelssohn una volta scrisse: “Un brano musicale che amo è in grado di trasmettermi dei pensieri che non sono troppo imprecisi per essere espressi in parole, al contrario sono troppo precisi”. La musica gode di un’assoluta precisione nel campo dell’esperienza che ne facciamo ed è, paradossalmente, questa precisione che la rende inaccessibile al senso. Proprio come accade al reale lacaniano. Eppure, se si tratta di rinunciare al senso, ciò può accadere soltanto dopo averlo percorso, dopo averlo cercato. Si tratta di un punto centrale nella lettura di Pagliardini: lo svezzamento dal senso, l’abbandono, la caduta, possono darsi solo perché c’è stata preventivamente una ricerca del senso condotta nel colore della mancanza e dell’inadeguatezza. “Constatiamo infatti che è per la via della castrazione, portandola all’osso, che Lacan arriva a mettere a punto il suo superamento, il fuori castrazione. (…) Detto altrimenti, Lacan deve arrivare al colmo del “non c’è” per precipitare sul “che c’è”, sul c’è del godimento sganciato dalla castrazione e dunque dal fantasma (pp. 158-159). Si dà incontro con il reale nel punto in cui la sottomissione al senso si converte nel superamento dello stesso. È dunque più chiaro il motivo che spinge Pagliardini a portarsi dietro sempre tutto Lacan, a non rinnegare la sua fiducia nel significante per celebrare le imponderabili risorse del corpo, a non sacrificare ab origine la ricerca del senso per gestire in modo puro e incontaminato la combutta col godimento. C’è scarto tra il primo e il secondo movimento, ma non si arriva al secondo senza la fatica del primo. Potremmo dire che anche il punto terminale in cui si arriva a toccare il ricetto del nostro godimento è di fatto l’esito di un residuo di dialettica.
Dunque quale postura dobbiamo assumere per incontrare il reale? La postura di un passo indietro, di una rinuncia, di un sacrificio che, tuttavia, prepara l’incontro affermativo e vitale con la presenza assoluta del godimento. Per intendere questa non facile torsione, dobbiamo seguire il discorso di Pagliardini, impegnato a sondare tutte le sfumature del sacrificio secondo un clinamen che va dalla sofferenza nevrotica alla possibile redenzione della fine analisi. Il sacrificio è in gioco sia nel primo sia nel secondo caso. La differenza consiste nel fatto che nella nevrosi a essere sacrificato è il godimento, mentre l’esito dell’analisi dovrebbe condurre a quella dose di rinuncia necessaria per inaugurare l’assenso al godimento. Ci sono in effetti due modi in cui la vita psichica può fare esperienza del sacrificio. Un modo, diciamo così, più leggero ma patogeno: si tratta dell’eterno sacrificio del godimento messo scrupolosamente in opera dal nevrotico, il quale inseguendo l’utopia di voler diventare padrone del proprio desiderio si condanna di fatto al sacrificio del godimento. E un modo più radicale, drastico ma salvifico e salutare: quello di chi sacrifica la ricerca di padronanza e si abbandona a un godimento residuale, di chi rinuncia a qualcosa per lasciarsi cadere in una nicchia di godimento che è ricettacolo e ricovero insieme. È qui in gioco un modo di godere che si ottiene sulla scia di un sacrificio, di un passo indietro che, però, è foriero di un certo grado di appagamento. “La fine analisi, a livello del godimento, rimane così legata al sacrificio. C’è un prezzo che bisogna continuare a pagare: non c’è più il godimento del sacrificio, ma c’è la necessità del sacrificio per accedere al godimento. È una fine analisi segnata dal rinunciare per ri-trovare” (p. 341). Per affermare questo, occorre ammettere che esiste una castrazione sganciata dall’Edipo e dall’interdetto della legge, liberata cioè dall’indefinito rinnovo della mancanza e dell’impotenza, una castrazione affermativa. Si tratta di un paradosso potente che regge tutto il discorso di Lacan sul godimento, in particolare nel Seminario X, cui di frequente Pagliardini rinvia, e che fa segno verso una rinuncia germogliante, verso un sacrificio che è l’anticamera del risveglio alla vita.
Ma c’è un passo ulteriore che Pagliardini muove in questo libro, seguendo la proposta più radicale dell’ultimo Lacan. Questa ulteriore mossa fa fuori il soggetto per dare la parola al godimento che si gode, al godimento puro, acefalo, impersonale. “A partire dal Seminario XIX, Lacan non solo mette a fuoco la questione del “c’è dell’Uno”, dunque coglie quel che rende ragione del “non c’è rapporto”, ma modifica la sua postura, cioè la posizione da cui si interroga e interroga il reale: non si tratta più di intendere il godimento a partire dal rapporto del soggetto con il godimento, ma a partire dal rapporto del godimento con il godimento. La questione non è più: “Che rapporto ha il soggetto con il godimento?” ma: “che rapporto ha il godimento con se stesso?” (p. 160). Si tratta senza dubbio della postazione più avanzata dell’insegnamento lacaniano, che Pagliardini sente come la direzione più coraggiosa e innovativa della psicoanalisi stessa, quella che la spinge verso una teoria dell’atto puro, dell’assoluta immanenza e che la tiene definitivamente lontana da ogni ortopedia psicologica e psicoterapeutica. Qui ogni dialettica si spegne e si produce un salto che inscrive l’umano nell’inumano. E allora forse quel progetto di portarsi sempre dietro tutto Lacan si interrompe a favore di un balzo che sacrifica definitivamente la nozione di esperienza. Mi chiedo a questo punto: chi resta lì a dar testimonianza di questo contatto col reale? Con quale diritto parliamo di contatto se a dileguarsi è propriamente chi tocca? In altre parole: è possibile mantenere almeno il ruolo di testimone del soggetto, anche quando si sia rinunciato alla sua funzione di padronanza e di articolazione? Sono queste le domande che rivolgo a Pagliardini in un dialogo virtuale e non solo.
giovedì , 3 Aprile 2025
Ultime notizie
- 194. Recensione a: Emanuele Coco, La fine degli spiriti. La natura come indagine filosofica del sé, Mimesis, Milano-Udine 2022, pp. 137. (Aurora Du Bois)
- 193. Recensione a: Alice Barale, L’arte dell’intelligenza artificiale: parole-chiave filosofiche, Jaca Book, Milano 2024, pp. 220. (Efrem Trevisan)
- 192. Recensione a: Venanzio Raspa, Origine e significato delle categorie di Aristotele. Il dibattito dell’Ottocento, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 304; Véronique Brière, Juliette Lemaire (éds.), Qu’est-ce qu’une catégorie? Interprétations d’Aristote, Peeters, Louvain-la-Neuve 2019, pp. VI-399. (Luca Gili)
- 191. Recensione a: Sofia Sandreschi de Robertis, Proust e l’abitudine. Identità, memoria, inconscio, Carocci, Roma 2024, pp. 208. (Enrico Palma)
- 190. Recensione a: Bruno Centrone, Vita in comune. Il pitagorismo nel mondo antico, Carocci, Roma 2024, pp. 292. (Federico Casella)
- 189. Recensione a: Nicola Zambon, Persuasione ed evidenza. Sul rapporto tra retorica e fenomenologia in Husserl, Heidegger e Blumenberg, Inschibboleth, Roma 2024, pp. 174. (Stefano Franchini)
- 188. Recensione a: Massimo Cacciari, Metafisica concreta, Adelphi, Milano 2023, pp. 423. (Stefano Piazzese)
- 187. Recensione a: Agnese Di Riccio, Alfredo Ferrarin, Guido Frilli, Danilo Manca (a cura di), La psicologia di Hegel. Un commentario, IISF PRESS, Napoli 2023, pp. 357. (Mario Pati)
- 186. Recensione a: Costantino Esposito (a cura di), Il nichilismo contemporaneo. Eredità, trasformazioni, problemi aperti, Studium, Roma 2024, pp. 557. (Sarah Dierna)
- 185. Recensione a: Andrea Scarabelli, Vita avventurosa di Julius Evola. Una biografia, Bietti, Milano 2024, pp. 816. (Igor Tavilla)

 English
English

